58 - Domande
Sin da bambini vogliamo risposte. Poi ci dimentichiamo come si fanno le domande.
I pensieri lunghi non sono fatti di risposte. Si generano anzi partendo proprio da domande e spesso restano tali: quesiti senza risposte o raccolte di ipotesi non suffragate da fatti, illazioni, tentativi.
Alcuni pensieri lunghi sono ipotesi o dubbi. Uno che mi frulla nella testa ultimamente - forse un bias cognitivo dovuto al fatto che ne sento spesso parlare e allora sono portato a rifletterci - è che non contano le risposte ma contano soprattutto le domande.
Fare domande non è per niente facile. Fare buone domande è tremendamente difficile. Per fare buone domande bisogna mettere insieme due condizioni molto precise: essere curiosi e non temere che la nostra domanda riveli ingenuità o impreparazione. Se facciamo domande è perché non sappiamo ancora le risposte (forse non le sapremo mai) e quindi la condizione di ignoranza è implicita e non lede alcuna dignità personale.
La prima domanda che tutti ci siamo posti è perché. Perché di notte c’è il buio, perché i poliziotti sono vestiti così, perché il sole scalda, perché la Coca Cola ha le bollicine. Sono le domande che ogni bambino prima o poi fa, specie a raffica, specie - oltre un certo punto - irritando gli adulti a cui le pongono. Che non sono infastiditi dall’insistenza quanto dal fatto che dare una risposta non è affatto semplice. Spesso insomma capita che i bambini facciano domande a cui si risponde stizziti con un “Perché è così!”. E in realtà non è affatto così, è che non sappiamo dare una risposta.
Quelle sono ottime domande e allora ho pensato a un altro genere di ottima domanda e non ho potuto che non pensare all’arte contemporanea.
Prima di arrivarci, facciamo però un passo indietro e cerchiamo di capire perché i bambini fanno domande. In primo luogo per soddisfare una comprensibile sete di conoscenza, per curiosità insomma. Soprattutto però le fanno per capire, per collocarsi nel mondo.
Con il tempo e con il condizionamento sociale si impara a capire che le domande espongono e rivelano l’interlocutore. Le domande mettono a nudo chi le fa, quasi più di quanto facciano con chi deve fornire delle risposte. Ed esponendolo, lo trasformano in soggetto attivo (che pone domande) in passivo (che subisce il giudizio altrui, per come pone domande e per il contenuto delle stesse).
Col tempo si è insomma sempre più cauti nel porle, sino a che si perde l’abitudine o l’ardire di farne.
È una grave perdita perché ogni evoluzione intellettuale comincia proprio da una domanda e la costruzione della cultura si basa proprio sulla volontà di trovare risposte a domande più o meno esistenziali, più o meno profonde.
La domanda è lo strumento della curiosità.
Dicevo che il porre domande mi ha fatto pensare all’arte contemporanea, specialmente a quella astratta e concettuale.
Senza addentrarmi in una disamina in merito - non ne ho le competenze e al più posso compensare con la curiosità che mi ha sempre fatto affrontare questo soggetto - si può dire che questo tipo di arte rappresenta una frattura netta nel rapporto che l’umanità ha con le arti figurative e plastiche.
Abituata per secoli a concepire l’arte come rappresentazione del reale o del divino (perché l’arte è stata per secoli e millenni solo figurativa), è comprensibile come abbia accolto con sospetto e distacco un linguaggio visivo che di riconoscibile non ha quasi niente.
Ho sempre trovato che l’arte contemporanea esercitasse una notevole attrazione su di me pur non fornendomi né appigli per capirla né risposte. Ricordo che quando vidi per la prima volta al MoMA la tela nera di Abstract Painting di Ad Reinhardt risi compiaciuto, pensando fosse uno scherzo. Quello che vedevo era un quadrato nero appeso a un muro, o una tela interamente dipinta di nero. La potrei anche rappresentare con un’emoji, eccola:
◼️
Il sorriso era forse imbarazzato. Non capivo se fosse una provocazione o qualcosa di talmente geniale da risultarmi incomprensibile.
C’è una celebre battuta che riguarda non solo quella tela ma in genere molte opere contemporanee: una coppia di persone è di fronte a una di queste opere e uno dice “Ero capace anche io di farla”, al che l’altro risponde “Sì, ma lui l’ha fatta per primo.”
Ovviamente l’arte contemporanea non è una gara a chi fa prima qualcosa che altri non hanno mai fatto. Quello che mi attrae è il fatto che - quando è buona o ottima arte - mi trovo di fronte a una domanda.
Una domanda può anche essere un silenzio, così come è silenzioso un quadrato nero che, figurativamente parlando, rappresenta solo se stesso. Un quadrato nero è un quadrato nero e se ci sei di fronte stai guardando un quadrato nero.
La grande rivoluzione dell’arte contemporanea è però un’altra: è quella di avere la forza di iniziare una conversazione molto particolare, cioè con se stessi.
Di fronte a un quadrato nero non ci si chiede cosa rappresenta (oddio, all’inizio magari sì) ma ci si chiede perché ci si trova in quella situazione, e cosa ci provoca guardarlo, e se ci fa pensare ad altro.
Può anche non succedere niente: in fondo la reazione a qualcosa non è l’esito di un meccanismo oggettivo che genera condizioni sempre valide ma dipende dalla sensibilità individuale.
Eppure anche essere infastiditi o sentirsi presi in giro da un quadrato nero o da una composizione astratta è una reazione, cioè una forma di dialogo.
Un dialogo è sempre generato da una qualche curiosità, così come una conversazione deve usare il desiderio di conoscere e capire per progredire. Una conversazione è insomma basata su domande e risposte e sul rapporto fra una ricerca di conoscenza e una fonte di conoscenza.
Per secoli questa conversazione ha avuto un’unica direzione: i dipinti e le sculture dicevano qualcosa rappresentando la realtà e il divino. Raccontavano di Dio o di Napoleone e davano una forma visibile a concetti o storie. Erano la forma di un rapporto fra divino e umano, emanando dal divino e illuminando l’umano. La relazione che si instaurava fra opera e osservatore era impari: l’opera - come dire - “irradiava” mentre l’osservatore non poteva far altro che contemplare e, per usare un’espressione oggi d’uso comune, “scaricare le informazioni” che vi erano contenute. Non a caso i grandi cicli pittorici erano strumenti educativi che raccontavano storie e davano una forma al racconto biblico o a quelli popolari.
Poi questo rapporto si è interrotto. L’arte contemporanea ha molti linguaggi e molte forme ma non ci trovo mai il divino dentro. Non è un giudizio morale - che sarebbe poi oltremodo fuoriluogo nell’arte - ma una constatazione. E non c’è Dio per un semplice motivo: in queste opere c’è l’umanità stessa che da più di un secolo indaga su stessa più che sul suo rapporto con il divino.
Dicevo prima che la rivoluzione dell’arte contemporanea è che contiene domande. Fra queste può essercene anche qualcuna su Dio ma fondamentalmente sono domande che riguardano solo l’umanità stessa e non hanno risposte. O ne hanno molteplici, tante quante se ne possono trovare in una composizione astratta.
Se però dovessi dire qual è la principale differenza fra arte figurativa secolare e astratta o concettuale direi che la prima fornisce risposte, la seconda pone domande. E facendolo, stimola a dare delle risposte.
Lo fa anche per un motivo semplice: non esiste in una dimensione morale e quindi non è soggetta al giudizio e non giudica chi la osserva. Non è un’arte che insegna (il divino, il potere) né sentenzia. È magari silenziosa o incomprensibile ma non rappresenta. Direi piuttosto che riflette.
Nell’arte contemporanea ci si riflette e, riconoscendoci, ci si interroga. Si inizia una conversazione con noi stessi. Si ritorna a fare domande che non si riusciva più a fare, come quelle che ci si poneva da bambini, quando Dio non esisteva e si voleva capire dove ci si trovava e cos’era questo e quello. Per capire, in fondo, chi eravamo e siamo.
Una cosa che mi è successa
La scorsa settimana è stata annunciata la seconda edizione di “Micros, un festival piccolissimo”. Ideato da Rocco Rossitto, Micros è un festival che non ha luogo e periodo di svolgimento e soprattutto ha modalità di funzionamento molto singolari.
Nella prima edizione è stato una conversazione su una terrazza milanese fra 14 persone, nella seconda - chiamata “1:100 Una mostra personale” - ha preso le sembianze di una mostra fatta con una sola foto misteriosa che non può essere vista in nessun luogo ma che si può solo ricevere a casa.
Chi la riceve e il caso decidono in quale modalità si consuma l’esperienza di questo festival perché questa foto si vede solo quando si apre la busta, e la vedono dove e come si trovano solo i primi 100 che hanno chiesto di riceverla gratuitamente.
La disponibilità delle foto è andata esaurita in pochi giorni (grazie a tutti i 100 che l’hanno richiesta) ed era esattamente questo lo scopo: non quello di fare sold out nel minor tempo possibile, ma, come spiega Rocco stesso, quello di fare vivere un’esperienza che “riguarda l’interazione personale e privata che la persona avrà con la mostra, la fotografia, il fotografo che l’ha realizzata e il curatore che l’ha pensata. Ogni giorno vediamo centinaia di foto nei nostri feed probabilmente per non più di 5 secondi. Qui spero che ci si fermi per qualche instante in più. Il contrario di abbondanza è scarsità certo, ma volendo anche importanza. Ci distraiamo in continuazione, viviamo in flussi di abbondanza continui. 1:100 Una mostra personale vuole cercare di dare valore ad un unità minima, alla reazione che si genera guardando una foto, una sola, in un momento privato.”
Inoltre
Puoi vedere altre mie foto, grafiche, disegni, e leggere molto altro su martinopietropoli.com.
➞ Sono anche su Twitter | Facebook | Instagram | Medium
➞ Le mie stampe sono su Studio Martino Pietropoli







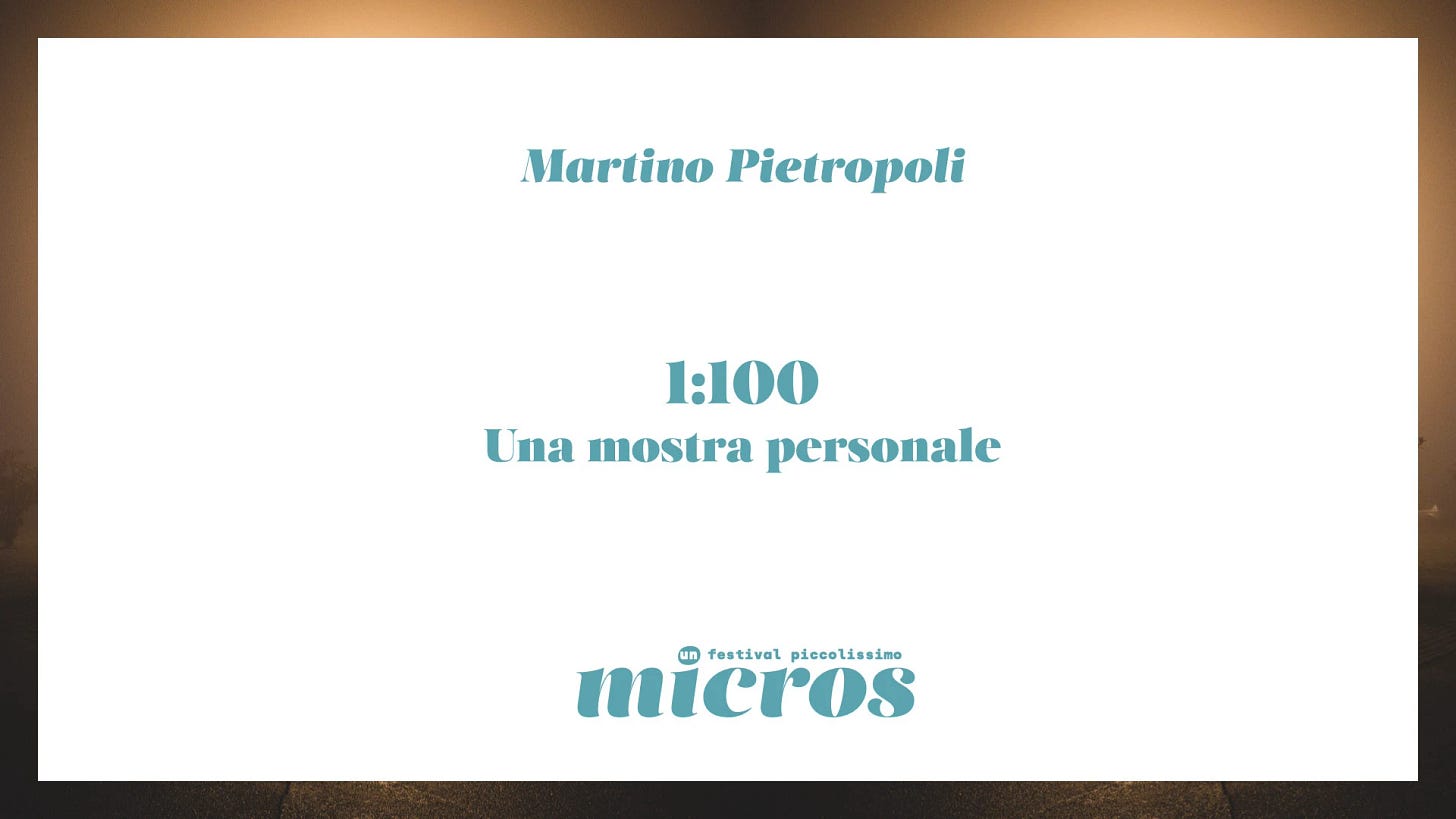
Ottimo pezzo, Martino. Su un tema complesso. "Quello che mi attrae è il fatto che - quando è buona o ottima arte - mi trovo di fronte a una domanda" -- questa è una di quelle rivelazioni, uno di quegli insights, che emergono sempre nei tuoi pensieri lunghi. Idee semplici, ma fottutamente complesse da raccontare. E tu ci riesci bellamente. Bravissimo. :)
bellissimo pezzo